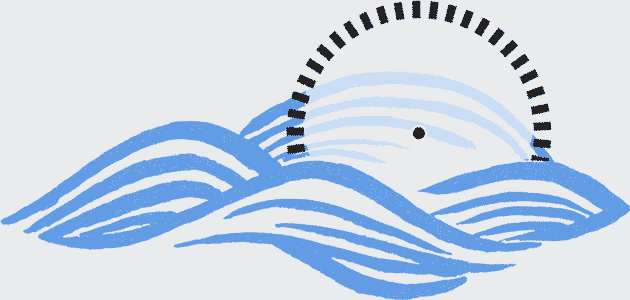La piazza è vitale
di Sauro Guarnieri
Prendo spunto da un recente articolo apparso sul settimanale Internazionale intitolato ‘Cambiamo le città’[1] dove si legge che “le innovazioni prodotte dalla crisi possono insegnarci molto, aiutandoci a creare una politica urbana che, al di là dell’emergenza, possa rendere la vita più piacevole e sicura per tutti”. La mia anima di architetto si è sentita tirata in ballo, e mentre nei giorni scorsi sembravano essere emersi ‘solo’ i risvolti ambientale ed economico, mi ha fatto piacere che si prendessero in considerazione le conseguenze della pandemia in merito al ripensamento degli spazi di socializzazione fisica. L’articolo evidenzia giustamente come il lockdown abbia prodotto “una significativa riduzione dell’inquinamento atmosferico. Secondo uno studio recente, le limitazioni imposte in Cina hanno salvato la vita di 77mila persone semplicemente migliorando la qualità dell’aria”. E anche sotto il profilo economico l’autore non manca di sottolineare come i piccoli negozi di quartiere siano stati “riscoperti grazie alla loro capacità di creare legami personali e alla loro dedizione alla comunità. È un’occasione per ripensare le aree commerciali del centro delle città, creando un’offerta diversificata che possa soddisfare le necessità della comunità e rafforzarla in vista di nuove crisi.” Non è un caso se poco dopo aver letto queste frasi mi è arrivato l’articolo pubblicato sul blog di Valdisieve in Transizione da Lorenzo Ci (con le belle foto di Andrea Sawyerr) con volti dei commercianti di Pontassieve, che il progetto ‘REconomia‘ sta cercando di valorizzare.

Sul fronte della pianificazione urbanistica si rileva come “gli edifici e i terreni abbandonati delle grandi imprese di costruzioni potrebbero essere assegnati alle organizzazioni di quartiere per favorire la solidità delle comunità locali attraverso la creazione di aziende agricole, attività per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, edilizia (eco-logica, ndr) spazi per il tempo libero, biodiversità e stoccaggio di carbonio.” Inoltre emerge anche la necessità di spazi per l’ossigenazione spirituale e fisica poiché “molte persone hanno notato quanto siano ridotti gli spazi verdi disponibili nelle città, e molte famiglie sono rimaste chiuse in ambienti ristretti senza accesso a spazi esterni. Le aree verdi pubbliche dovranno essere ampliate per permettere alle persone di riunirsi e riprendersi dopo il trauma del covid-19.” Problema che forse sarà stato meno sentito dagli abitanti dei centri di Pontassieve e altri paesi più piccoli, che possono contare su fiumi e colline verdi nell’immediato contorno urbano, ma credo che già i residenti del centro di Firenze possano confermare le situazioni descritte.
L’articolo si conclude con un doveroso slancio politico – poiché l’urbanistica ne è l’estensione pragmatica con la quale la politica si fa materia – rimandando la responsabilità non solo agli amministratori ma anche ai singoli cittadini (i quali creano la domanda di spazi scegliendo come vivere la città, dove incontrarsi, dove acquistare o dove stare in santa pace da soli) e sentenzia: “il futuro delle città non è già deciso. Le esperienze positive che abbiamo intravisto durante questa crisi possono essere rafforzate e ampliate per creare un contesto urbano più equo, verde e sicuro. Se rimettiamo al centro delle nostre priorità la comunità, le amicizie e la vita familiare, scopriremo che abbiamo già molte risorse per migliorare la nostra vita”; occorre “battersi per uno stato democratico e partecipativo in cui le soluzioni siano concordate con i cittadini invece di essere imposte dall’alto.”
E siccome reagire ai cambiamenti in modo creativo è uno dei principi fondanti del pensiero permaculturale mi sono chiesto quale fosse la cellula base, il modello di interazione minimo da vitalizzare a livello urbano: la piazza!
Il ruolo della piazza è da millenni determinante nella caratterizzazione dello spazio collettivo. Dai libri di storia classica occidentale apprendiamo la discendenza delle piazze europee (e per successive esportazioni coloniali in buona parte del mondo civilizzato, appunto da civis ‘cittadino’) dall’agora greca e dal forum romano, anche se potremmo presto includere origini più locali, confidando nel lavoro degli archeologi sullo studio della città di fondazione etrusca Kainua (VI sec. a.C.), dove “gli scavi nell’area antistante il tempio tuscanico potranno verificarne l’esistenza (della piazza, ndr) in relazione al Santuario urbano, fulcro della vita cittadina”.[2]
Nell’uso comune il termine latino forum, da “spazio intorno alla casa e alla tomba; più tardi, centro religioso, commerciale, amministrativo, culturale della città” ha quasi perso la sua connotazione fisica e simbolica, indicando al massimo un edificio per lo “svolgimento di manifestazioni pubbliche di vario genere” o spazi virtuali che ospitano “riunioni pubbliche per discutere argomenti” (talvolta suddivise in temi o thread di discussione), mentre il sostantivo maschile ‘foro’ viene ormai associato alla sola sfera giuridica.[3]
In realtà la parola ‘piazza’ proviene dal latino platĕa ovvero ‘via larga’.[4] Nell’uso mediatico degli ultimi decenni viene utilizzata spesso per rappresentare un luogo dove avvengono scambi più economici che sociali (‘piazza affari’, ‘assegni fuori piazza’, ‘rovinare la piazza’, ecc.)… non dovremmo sorprenderci di questa deriva concettuale poichè anche lo sviluppo di Castel S. Angelo al Pontassieve si deve in buona parte al mercato che nacque nel 1399 proprio al crocevia delle relazioni commerciali tra Firenze, il Valdarno superiore, la Valdisieve e il Casentino.[5]

Arrivando ai giorni nostri la vivibilità delle piazze è tornata di grande attualità attraverso le implicazioni del distanziamento sociale imposto dai decreti ministeriali. Il coronavirus ci sta offrendo l’opportunità di riflettere sul potere della piazza, dell’incontro, dello scambio umano.
Nelle scorse settimane di sfrenate relazioni virtuali, partecipando alla chat del Mercato in Transizione di Pontassieve, abbiamo visto la difficile vita di alcuni luoghi come piazza Tasso a Firenze, interdetta al mercato contadino a causa della sua conformazione ristretta, mercato che è stato prima spostato in piazza del Carmine e poi chiuso dall’amministrazione comunale, perché bersagliato da polemiche scaturite in buona parte da alcune foto il cui zoom ha accorciato le distanze tra le persone. Poi è saltata fuori anche l’immagine di una piazza molto cara al territorio della Valdisieve e del Mugello, quella di Vicchio che, ripresa credo da un drone, mostrava una scacchiera di quadrati bianchi intorno alla centrale statua del natio Giotto di Bondone (foto di copertina): tra chi gridava allo scandalo e chi apprezzava il tentativo di design urbano contemporaneo (io), si è creato un dibattito di piazza sulla piazza! Bello? Brutto? Utile? Superfluo? Non so, ma in fondo parafrasando Wilde: l’importante è che se ne parli![6]
A questo serve la piazza, a metterci in contatto con la diversità, con il pensiero dell’altro da me, infatti anche la piazza rappresenta un margine in permacultura, un’ecosistema di incontro-scontro tra privato e pubblico, tra la mia casa protetta dal freddo, dalla pioggia, dagli sguardi indiscreti e un luogo aperto dove si corre il rischio (brutto e bello!) di esporsi ad accadimenti quasi mai prevedibili.
L’idea che abbiamo maturato nella nostra riflessione domestica viene messa in discussione dal confronto di piazza, correndo il rischio di cambiare, o almeno di tornare a casa con un’idea in più. Gli stereotipi che ci siamo costruiti, da soli o con l’aiuto dei mezzi di informazione di uso personale (tv, cellulare, desktop, laptop, tablet, chi più ne ha ne metta), vengono messi a dura prova dall’opinione che hanno l’amico, la conoscente, gli artigiani, il vigile urbano, la podista, i bambini che incontriamo in piazza, ognuno e ognuna con i propri bisogni e la propria ‘ragione’, riflessione, storia e accaduto personali. Serve una buona dose di ascolto, messa in discussione, rispetto e spirito di socializzazione insieme… insomma la disponibilità a mescolarsi un po’, e la piazza è fatta!
Un tentativo che il gruppo del Mercato ha cercato di mettere in atto facendo una riunione all’aperto, distanti e senza obbligo di mascherina (anche se c’è chi ha preferito tenerla), ma riappropriandoci di un luogo e di una modalità che evidentemente mancava: il confronto umano fatto di parole ma anche di gesti, sguardi, espressioni facciali e non verbali: è stata una forma di ri-contatto, un po’ più vicini con tutto il corpo e non solo con la mente, che si sa, spesso… mente.
Sauro Guarnieri, bioarchitetto e permacultore, vive in Valdisieve dove facilita il progetto di agricoltura sociale ‘Radici Umane’ di Pomino (Rufina), partecipa al gruppo di autoapprendimento in comunicazione empatica di Pontassieve e co-conduce laboratori di espressione umana con Mescolarsi teatro sociale.
[1]L’articolo è stato scritto da Paul Chatterton, insegnante di urbanistica del futuro all’università di Leeds, Regno Unito; Internazionale 1359 del 22 maggio 2020, pp. 16-20.
[2]Elisabetta Govi, Marzabotto. La città fondata in AA. VV., Etruschi, viaggio nelle terre dei Rasna (Electa, 2019)
[3]cfr. voci forum, foro su www.treccani.it
[4]piazza s. f. [lat. platĕa «via larga, piazza» (dal gr. πλατεῖα, propriam. femm. di πλατύς «largo»); cfr. platea, che risale a una variante lat. platēa con e lunga]. – 1. a. Area libera, più o meno spaziosa, di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligonale, che si apre in un tessuto urbano, al termine di una strada e più spesso all’incrocio di più vie, e che, limitata da costruzioni, spesso architettonicamente importanti, e abbellita talvolta da giardini, monumenti, fontane, ha la funzione urbanistica di facilitare il movimento ed eventualmente la sosta dei veicoli, di dare accesso a edifici pubblici, di servire da luogo di ritrovo e di riunione dei cittadini, costituendo non di rado il centro della vita economica e politica della città o del paese. (www. treccani.it/vocabolario/piazza)
[5]Emanuele Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana.., vol. I, voce Pontassieve.
[6]“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.” (C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé), Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (1891)